Tutti i libri facili si somigliano; ogni libro difficile è difficile a modo suo, mi dico, parafrasando il sommo. E poi ci sono i libri di Melissa Broder che sono semplicemente altro/oltre. E tradurli è un immenso privilegio, ma anche una grande responsabilità.
Un paio di anni fa, quando NNE mi ha proposto di tradurre Affamata, ho accettato con entusiasmo. Salvo poi passare mesi a dare testate al muro. Con Death Valley è stato perfino peggio. La prima volta che l’ho letto, ho pensato: Speriamo che NNE lo pubblichi. E poi, in un lampo fugace di lucidità: Oddio no, perché magari mi chiedono di tradurlo, e io non ne esco viva. Naturalmente, quando hanno deciso di pubblicarlo e mi hanno chiesto di tradurlo, ho accettato al volo, perché “il cuore ha le sue ragioni” eccetera. E comunque, spoiler non troppo spoiler: ne sono uscita viva. Del resto, Death Valley è, tra le varie cose, anche una storia di sopravvivenza.
La verità è che, per quanto il mio rapporto con questo mestiere (che può essere piuma e può essere ferro) sia molto poco romantico, quando c’è di mezzo lei, Melissa Broder, le cose cambiano.
Tradurre, o perlomeno tradurre narrativa, è prima di tutto intonarsi a voci che non sono la nostra. Non a caso, i bravi traduttori non hanno – o non dovrebbero avere – una voce personale forte, riconoscibile; questo li rende più duttili, li aiuta a scomparire, a farsi megafono della voce altrui.
Quando traduco Melissa Broder, però, si compie una specie di prodigio: diversamente dal solito, non devo fare nessuno sforzo per intonarmi alla sua voce, non ho bisogno di cercarla, per il semplice fatto che la sento riecheggiare fortissimo dentro di me, quindi devo solo seguirla – in quel solo c’è un mondo, ma non vorrei partire per la tangente più di quanto non stia già facendo.
Con Affamata, e forse ancora di più con Death Valley, anche mentre davo testate al muro, ho sempre avuto l’impressione di sapere con esattezza dove stavo andando, cosa stavo facendo. Tutte le micro- o macroscelte che sono l’ossatura stessa della traduzione, nonché il frutto di lunghi e logoranti processi mentali (la traduzione è quella cosa che succede mentre ti fai i film nella testa), nel caso dei romanzi di Melissa Broder, sono segnavia che ti (mi?) indicano la strada, il sentiero da percorrere.
Death Valley è un libro folle. E sublime. È un libro nel quale ogni singola parola è in relazione con tutte le altre; è una costellazione di rimandi interni che trasforma la traduzione in un periplo, in un infinito proiettarsi in avanti per tornare indietro: niente più punti di riferimento, niente più coordinate, continui salti da un ignoto all’altro, biforcazioni che si rivelano forchette a tre rebbi e che ti costringono a chiederti: e adesso, in che direzione vado? Quando traduci un libro del genere, “buona la prima” è, nel migliore dei casi, una pia illusione: le riletture si moltiplicano, e a ogni rilettura scopri qualcosa – un dettaglio, una sfumatura – che ti era sfuggito, o al quale non avevi dato il giusto peso, e che getta nuova luce su tutto il resto.
La lingua di Death Valley è visibilmente meno esuberante della lingua di Affamata, ma forse è un filo più subdola, anche perché abbraccia molteplici campi lessicali. C’è la terminologia geografica del deserto, c’è la tassonomia animale e vegetale, c’è il gergo New Age e quello ospedaliero, ci sono i post su Reddit e gli sms con gli errori di battitura, e ovviamente ci sono riferimenti culturali ovunque. Perciò, di volta in volta, ho dovuto trovare soluzioni che oltre a non tradire lo spirito dell’originale ne riproducessero il flow – poche volte mi è capitato di imbattermi in una scrittura con un ritmo e una musicalità paragonabili a quelli di Melissa Broder. Anche in questo caso, però, non ho dovuto inventarmi niente; è bastato ascoltare, sintonizzarsi sulle sue frequenze. Sh-boom.
Ora che ci penso, leggere e tradurre Death Valley, è stato un po’ come perdersi nel deserto. Perdersi però può fare bene, può fare bene all’anima: a volte, bisogna cadere per risollevarsi, andare in pezzi per ricomporsi; a volte bisogna perdersi per ritrovarsi. Ecco qual è, per me, la lezione più grande di questo romanzo. Di questo romanzo che è stato un viaggio spaventoso ed esaltante, un gorgo e un’àncora, un incubo e un sogno, in una parola: TUTTO. Un romanzo nel quale mi auguro riuscirete a perdervi anche voi. Ovviamente, per poi ritrovarvi.
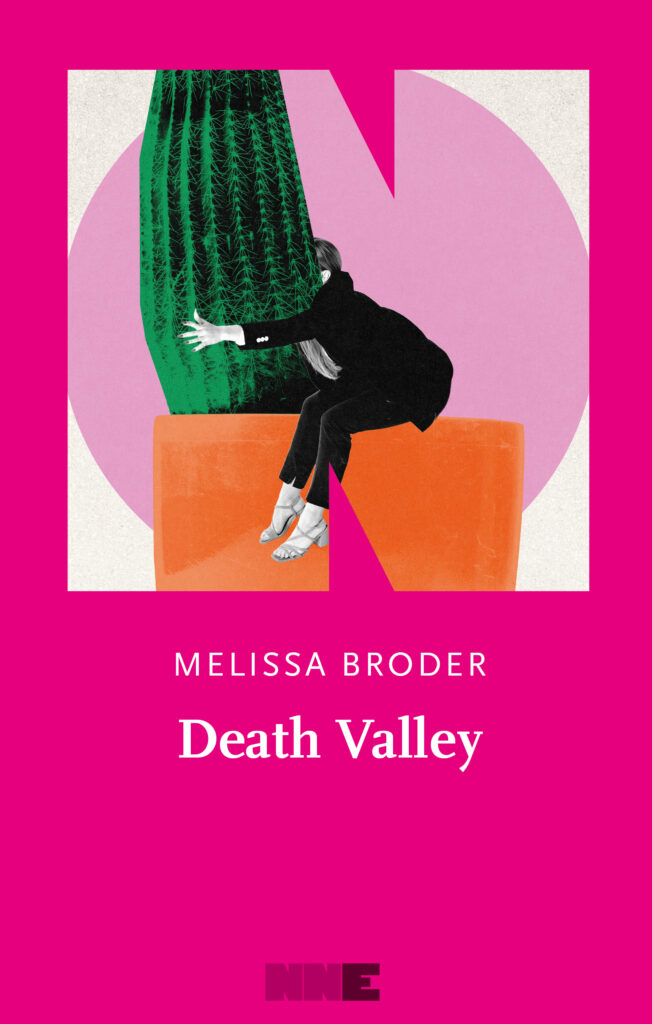
DISCLAIMER: I miei post non hanno la presunzione di rivelare la verità assoluta. Sono solo riflessioni di una traduttrice tra tante. Dicono qualcosa del mio approccio a questo lavoro, che non è l’unico e – soprattutto – non è necessariamente quello migliore. Ma tant’è.



